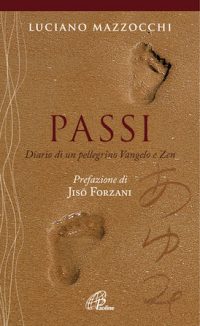ama il prossimo tuo come te stesso
keiten aijin
«Ama il prossimo tuo come te stesso»! Nel Vangelo predicato dal Cristo, questo comando è l’altro aspetto dell’amore verso Dio; come l’amore verso Dio è l’altro aspetto di quello verso il prossimo. Inscindibili, l’uno la porta e la via dell’altro, come due ali che solo insieme sono le due ali che mettono in atto il volo della speranza e della pace. Facendo memoria della testimonianza di padre Giovanni Vannucci: «Ama con i tuoi buoni e i tuoi cattivi istinti», accolgo l’invito a scrivere anch’io alcune considerazioni da condividere con gli amici delle Stinche e di Fraternità.
«L’amore dell’uomo verso il proprio simile è comandato da ogni cammino religioso ed è anima intrinseca di ogni cultura che ha costruito la storia umana. I giapponesi amano ornare la parete della loro casa che fa da sfondo al piccolo altare casalingo, dove conservano le ceneri degli antenati, appendendovi un rotolo di carta di riso su cui è scritta la massima di un grande maestro dell’umanità. Alcuni, soprattutto i cristiani, espongono una frase del Vangelo; ma in assoluto le massime più ricorrenti sono quelle della tradizionale sapienza dell’Oriente. Ne ho trovato una particolarmente frequente e amata: è del grande maestro cinese Confucio. Eccola: KEITEN AIJIN. Ossia: venera (kei) il cielo (ten) – ama (ai) l’uomo (jin). Ho voluto ricordare questa usanza giapponese per rendere omaggio alla sapienza universale che a tutti i popoli, da sempre e ovunque, ha indicato la via dell’amore reciproco come la via maestra dell’umanità. Questo riconoscimento è prima di tutto un dovere di onestà, perché così è; inoltre effonde in me cristiano una profonda gioia, in quanto mi mette sulla via giusta per comprendere e testimoniare il comando di amare il prossimo come se stesso, ribadito così fortemente da Gesù. La lieta notizia del Vangelo, infatti, non consiste tanto nel fatto che Gesù abbia insegnato ciò che mancava, che non era mai stato detto; ma piuttosto nel carisma di grazia e di profumo che ha riversato sopra a una legge scolpita nell’intimo dei cuori fin dall’inizio. Il Vangelo è il lieto annuncio di una qualità, di un profumo, di un sapore, di un’intensità, riversati su ciò che da sempre e ovunque è. Soprattutto è evidente circa il precetto dell’amore. Così il cristiano non ha la missione di presumersi l’ambulanza del pronto soccorso che salva il mondo in extremis, ma quella di testimoniare che l’amore vicendevole, che tutti percepiscono nelle fibre del loro cuore, è cammino reale, saporito, soave, anche nelle situazioni che la ragione umana non riesce più a decifrare, come è la minaccia della guerra e del terrore di questa cupa fine inverno 2003. Anzi! Proprio là dove il limite umano diviene difficoltà, la grazia dischiude la porta alla via maestra dell’amore. La chiave di quella porta è il perdono!
Gesù raccolse il precetto dell’amore verso il prossimo già enunciato dall’Antico Testamento e, riversandovi il carisma del Vangelo, lo pose a fondamento del Nuovo. Il carisma cristico può definirsi così: l’uomo entra nella capacità di amare non dalla porta della sua bravura, né da quella della sua innocenza; entra invece dalla porta del suo limite e perfino dei suoi peccati. Alla via dell’amore si accede soltanto chinando il capo, non perché si è così bravi da possedere perfino la virtù dell’umiltà, ma perché si è peccatori bisognosi di perdono fraterno. Con il capo chino, l’uomo può amare come Dio ama: gratuitamente, senza profanare l’amore con sottintesi di profitto o vanto personale! L’uno peccatore che si converte diviene capace di amare di quell’amore evangelico che riempie il cielo di gioia; mentre i novantanove giusti, pur con la montagna dei loro atti di amore senza chinare il capo, lasciano il cielo cupo.
«Ama con i tuoi buoni e i tuoi cattivi istinti». Convengo pienamente che senza la partecipazione dei cattivi istinti, difetti, insuccessi, incongruenze, oso dire anche scandali che di conseguenza richiedono l’umiliazione di chinare il capo e chiedere perdono, senza il ruolo di questa negatività, le sole virtù non fruttano il vero amore. Il solamente virtuoso non sa amare di quell’amore che sprizza gioia nel grande cielo di Dio.
Scrivo queste righe oggi, prima domenica di quaresima di quest’anno B, in cui si legge lo scarno ed efficacissimo Vangelo secondo Marco. Il Vangelo di oggi narra la tentazione di Gesù nel deserto così: «Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano». Nell’omelia mi sono permesso di citare il testo originale in lingua greca a quel drappello di gente comune che gremiva la chiesa, e, pur ignari del greco antico, mi parve che tutti abbiano assaporato la pregnanza delle parole originali. Dice il testo greco: «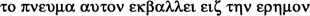 », che in italiano è tradotto: «lo Spirito lo sospinse nel deserto». Facevo notare quel verbo:
», che in italiano è tradotto: «lo Spirito lo sospinse nel deserto». Facevo notare quel verbo:  , che letteralmente significa: buttò fuori. Lo Spirito, che poco prima, al momento del battesimo, aveva tributato onore a Gesù librandosi sopra il suo capo in forma di colomba, subito dopo lo buttò fuori da quella gratificante esperienza del battesimo e della voce del Padre. Lo buttò fuori nell’aperto deserto. Dall’esaltazione, alla contrarietà. L’illuminazione del battesimo, la solitudine del deserto, la voce del Padre che lo proclama figlio diletto, la tentazione del diavolo che lo istiga a peccare, le fiere che ruggiscono, la consolazione degli angeli: tutto è l’opera dello Spirito. È il suo gioco! Via del deserto e della prova in cui a volte si vince e a volte si perde; ma sia la vittoria come la sconfitta svolgono il loro ruolo nella via dell’amore. L’evangelista Marco, il più antico, non ritiene necessario annotare che Gesù nel deserto vinse contro il tentatore; ma soltanto registra che fu tentato. Perché la tentazione non ha il suo senso soltanto qualora si vinca, ma anche quando si perde. Fosse soltanto per vincere, ci porterebbe al vanto. Ma anche quando si perde, la tentazione accade dentro il gioco dello Spirito. Chi non è mai caduto nella tentazione, non potrà mai amare l’altro mentre è nel crogiolo della tentazione come se stesso, perché il suo se stesso non conosce l’amarezza dello stato d’animo dopo la caduta, quando uno si trova a tu per tu con il suo limite e la sua debolezza. È il chiaro insegnamento della stupenda Lettera agli Ebrei in cui l’umile condizione umana che comportò a Gesù l’esperienza della sofferenza è indicata come un grado più perfetto sia dell’angelicità, sia della stessa figliolanza divina. «Quel Gesù, che fu fatto poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti… Infatti proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,9 e 18). Inferiore agli angeli per creazione, ne diviene superiore attraverso la vocazione a morire. La morte dà all’uomo di raggiungere l’apice di una gloria che, purtroppo, agli angeli non è data. La Lettera scrive ancora: «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,8-9). Suona come una bestemmia; eppure è scritto nel libro sacro che Dio è reso perfetto imparando l’obbedienza dalle cose che soffre! Stralci della Scrittura che dischiudono a visioni intensamente profonde sul dramma umano, finora non tentate e probabilmente impedite dal tenace permanere nel cristianesimo della theologia gloriae di marchio pagano. Dio come grande capo! La perfezione come trascendenza! La gioia come privilegio di non soffrire! La gloria come esaltazione! Al punto che di queste tinte colorano il paradiso non pochi cristiani.
, che letteralmente significa: buttò fuori. Lo Spirito, che poco prima, al momento del battesimo, aveva tributato onore a Gesù librandosi sopra il suo capo in forma di colomba, subito dopo lo buttò fuori da quella gratificante esperienza del battesimo e della voce del Padre. Lo buttò fuori nell’aperto deserto. Dall’esaltazione, alla contrarietà. L’illuminazione del battesimo, la solitudine del deserto, la voce del Padre che lo proclama figlio diletto, la tentazione del diavolo che lo istiga a peccare, le fiere che ruggiscono, la consolazione degli angeli: tutto è l’opera dello Spirito. È il suo gioco! Via del deserto e della prova in cui a volte si vince e a volte si perde; ma sia la vittoria come la sconfitta svolgono il loro ruolo nella via dell’amore. L’evangelista Marco, il più antico, non ritiene necessario annotare che Gesù nel deserto vinse contro il tentatore; ma soltanto registra che fu tentato. Perché la tentazione non ha il suo senso soltanto qualora si vinca, ma anche quando si perde. Fosse soltanto per vincere, ci porterebbe al vanto. Ma anche quando si perde, la tentazione accade dentro il gioco dello Spirito. Chi non è mai caduto nella tentazione, non potrà mai amare l’altro mentre è nel crogiolo della tentazione come se stesso, perché il suo se stesso non conosce l’amarezza dello stato d’animo dopo la caduta, quando uno si trova a tu per tu con il suo limite e la sua debolezza. È il chiaro insegnamento della stupenda Lettera agli Ebrei in cui l’umile condizione umana che comportò a Gesù l’esperienza della sofferenza è indicata come un grado più perfetto sia dell’angelicità, sia della stessa figliolanza divina. «Quel Gesù, che fu fatto poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti… Infatti proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,9 e 18). Inferiore agli angeli per creazione, ne diviene superiore attraverso la vocazione a morire. La morte dà all’uomo di raggiungere l’apice di una gloria che, purtroppo, agli angeli non è data. La Lettera scrive ancora: «Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,8-9). Suona come una bestemmia; eppure è scritto nel libro sacro che Dio è reso perfetto imparando l’obbedienza dalle cose che soffre! Stralci della Scrittura che dischiudono a visioni intensamente profonde sul dramma umano, finora non tentate e probabilmente impedite dal tenace permanere nel cristianesimo della theologia gloriae di marchio pagano. Dio come grande capo! La perfezione come trascendenza! La gioia come privilegio di non soffrire! La gloria come esaltazione! Al punto che di queste tinte colorano il paradiso non pochi cristiani.
In una parrocchia dell’Alta Lodigiana ho appena terminato la messa vespertina di oggi, prima domenica di quaresima, in cui ho proclamato il Vangelo di Gesù sospinto nel deserto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo, e, come sto per uscire dalla chiesa, un uomo, forse quarantenne, mi chiede un colloquio. È un fratello che si percepisce nella più profonda desolazione del deserto, per cui esistenzialmente cerca un po’ della consolazione degli angeli. Unico sopravvissuto di quattro fratelli, tutti e quanti caduti nella tentazione che li incatenò all’AIDS, ora si è legato con una donna che lo ama e che gli partorirà un figlio. La sua unica preghiera è: che nasca sano! È ritornato in chiesa dopo decenni, per chiedere questa grazia! Il Vangelo del deserto e della tentazione gli ha penetrato il corpo e l’anima, fino al midollo. Così ora si rivolge a me prete che ho presieduto l’eucaristia, chiedendomi di svolgere per lui, già tanto tentato e ferito dal diavolo, la funzione angelica della consolazione. Come sacerdote, nonché come essere umano, svolgo la funzione richiestami, percependo la santità di tale ruolo, e anche la gioia; ma ugualmente rammentando, all’ascolto delle negatività altrui, le mie proprie tentazioni, cadute, ferite, scandali, risurrezioni. Tuttavia proprio il ricordo dell’opera del diavolo dentro la mia vita mi aumenta la gioia di svolgere la funzione degli angeli per quel fratello. Diavolo e angeli: al servizio dello Spirito che guida alla conversione dell’amore. Amare perché si è amati, perdonare perché si è perdonati, onorare perché si è onorati, senza alzare polvere, nemmeno quella della consapevolezza che si sta amando; come il frutto che addolcisce la sua polpa sotto i raggi del sole non separa la funzione della sua maturazione dalla grazia che riceve. Così comprendo quel «come te stesso» del comando del Vangelo al passivo, piuttosto che all’attivo. Ossia mi dice: ama come tu stesso sei amato! Più volte ho inteso le stesse parole all’attivo, nel senso di: come io amo me stesso, secondo il mio modo di amare; perciò mi sono sentito protagonista del mio amore, modello a me stesso, inficiando l’amore di orgoglio e vanità. È questa la profanazione più presente nella carità cristiana: ergersi a coloro che danno amore, mentre ai poveri spetta la parte non onorifica di soltanto ricevere. Spesso, nella liturgia della chiesa soprattutto nelle orazioni iniziali della messa dette colletta e nelle preghiere dei fedeli, si domanda la grazia dell’amore. Tutte queste orazioni chiedono sempre la grazia che noi cristiani possiamo amare gli altri; è mancante invece l’altra domanda, quella che i cristiani possano beneficiare della grazia e dell’amore degli altri, forse dei poveri del mondo o dei non cristiani. Nella mente umana predomina l’idea dell’amore come attivismo, di cui se stesso è il soggetto e gli altri l’oggetto. Anche quando chiediamo all’altro di amarci, chiediamo che ci rivolga il suo protagonismo, le sue coccole, i suoi doni, le sue preferenze, il suo affetto. Si tratta sempre di chiedere amore fra pari, come dire: ora tocca a te perché prima è toccato a me. Chiediamo l’amore altrui di cui ci sentiamo degni e padroni. Par condicio anche nella legge dell’amore. L’uomo fatica ad accedere a quell’amore in cui non c’è protagonismo alcuno, dove sia il dare amore come il riceverlo rimane atto gratuito, umile e semplice, che non alza la polvere del vanto. Fatica perché l’uomo entra nella via dell’amore dalla porta della sua realizzazione, a testa alta, da protagonista. Così, amando, ne trae profitto; per lo meno quello di essere lui colui che occupa la parte di chi ama e non di chi riceve.
Il deserto è il luogo dove non c’è alcun posto alla cui ombra rifugiarsi quando il sole brucia; né alcun muro dietro cui ripararsi se il vento imperversa. Nel deserto l’uomo ha solo se stesso, le sue energie, le poche scorte che può portare con sé; porta con sé soltanto il suo limite e non può trasbordare qua e là spadroneggiando. Può resistere soltanto traendo fuori dal limite del suo sé le energie per resistere. Non può prendere nulla in prestito. Nel deserto l’uomo sperimenta che il suo limite è la dimora della sua forza. Nel deserto l’uomo è limite e forza assieme. Chi ama conoscendo solo la sua forza, ama dall’alto verso il basso, giudicando. Chi ama conoscendo solo il suo limite, ama dal basso verso l’alto, con la brama e la scontentezza nel cuore. Chi ama conoscendo la sua forza nel suo limite e il suo limite nella sua forza, ama conciliato con se stesso. Così può amare l’altro come se stesso. Può amare l’altro reale, e non la sua aspettativa sull’altro. Può amare l’altro reale; e non l’altro come la sua mente lo idealizza, o come il suo pessimismo lo squalifica.
«Ama con i tuoi buoni e i tuoi cattivi istinti»: sì, perché l’amore non ricerca un raggiungimento privato, o un merito personale. L’amore non è uno strumento per raggiungere o far raggiungere Dio; ma è la qualità di Dio in noi. «Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (I Gv 4,12). Dove c’è amore, c’è Dio nella sua perfezione. Il carisma cristico che Gesù riversa sulla legge universale dell’amore è appunto questa disposizione ad amare senza aggiungere alcuna altra ragione all’amore, se non la riconoscenza che è Dio che ama in noi. Come un frutto maturato perfettamente non necessita di alcun altro sapore aggiunto! Ugualmente l’amore non subisce ostacoli dai nostri demeriti, perché, come uno ama, anche fosse il più grande peccatore, l’amore libera immediatamente la qualità più intima della sua persona che direttamente comunica con Dio. Meglio, quando il peccatore ama, è Dio che ama in lui, forse usando gli stessi strumenti con cui il peccatore ha peccato. Così, anche la prostituta «ha amato molto» mettendo in atto le sue abitudini professionali: lavando i piedi a Gesù, asciugandoli con i suoi lunghi capelli, baciandoli, cospargendoli di profumo. Non cambiò il vasetto di profumo, ma usò quello del suo mestiere, per profumare quel corpo santo che a giorni sarebbe stato sepolto. «E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco» (Lc 7,44-47).
Lo Zazen è la pratica in cui – insegnano i maestri dello Zen – l’uomo ritorna alla sua posizione e al suo comportamento più autentici; in altre parole è la via del rincasare dentro se stesso. Consiste infatti nello stare seduti composti, svegli e solidi sul cuscino che è l’esistenza quotidiana. «Senza pensare né al bene, né al male, non curarti di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato… Non misurare quanto hai realizzato la via di Budda: essa non ha niente a che fare con lo stare seduti o sdraiati… Se a lungo compi questo, certamente diventi questo. Lo scrigno dei tesori si apre da se stesso, e tu ricevi e usi a volontà»: così raccomanda il grande maestro Doghen nel suo testo dal titolo Fakanzazenghi (La forma dello Zazen che è invito universale). Stare in silenzio, composti, svegli e solidi, senza appoggiarsi né a un sé idealizzato dal nostro narcisismo né a uno squalificato dal nostro pessimismo. È lo stare sveglio, composto, solido e in silenzio delle montagne; è la via dello Zen. «Ama il prossimo tuo come te stesso»: è il comando del Vangelo. Come te stesso! Composto di bontà e di cattiveria, di virtù e di difetti, senza lasciare fuori nulla: amare! E, amando, divenire amore! Senza nemmeno alzare la polvere della consapevolezza di amare! Così hanno amato le nostre mamme, con le loro doti e con i loro limiti, imparando ad amare mentre amavano!
Padre Luciano Mazzocchi, missionario saveriano
Galgagnano 9 marzo 2003
Nessun tag per questo post.