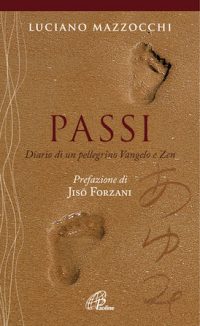Ciao padre Luciano,
inoltro il testo di una relazione di padre Dufour, tenuta il 3 Giugno a san Gregorio al
Celio. (www.camaldolesiromani.it)
Ho acquistato il suo ultimo libro e, leggendolo, vengo fatto destinatario della empatia profonda tra Oriente ed Occidente
grazie
Giandiego
(segue la riflessione, disponibile anche  qui in PDF)
qui in PDF)

* CHI DUNQUE È L’UOMO?
A questa dornanda è molto difficile rispondere?
Vorrei finire il ciclo delle conferenze con una considerazione d’ordine antropologico, insistendo sull’aspetto della relazione di ciascuno di noi con l’altro. Molta gente pensa che la vita terrestre consiste in un comportamento onesto: lavorare, procreare, non rubare, poi aspettare la morte senza paura.
Così non ci si preoccupa di una realtà che si impone a tutti gli uomini: l’esistenza della donna, cioè della tendenza femminile presente in noi tutti.
Questa donna è fondamentalmente insoddisfatta, testimone di un orientamento verso l’altro. Così 1’uomo pare un essere dialogale. Benché non possiamo esaurire la questione, è possibile entrare nell’argomento: l’uomo si realizza attraverso l’incontro dell’altro.

I. ANTROPOLOGIA
Secondo la concezione classica, l’uomo è un individuo fatto di un corpo e di un’anima. La vita in società, anche se di fatto si impone a tutti, non è di conseguenza un fenomeno intrinsecamente legato alla natura dell’uomo. Si ritiene che il corpo sia destinato a scomparire, mentre l’anima (almeno secondo i cristiani) è destinata alla vita eterna, alla felicità senza fine. Un episodio illustra questa mentalità: una bambina tornava da una visita al cimitero dove era appena stata sepolta la nonna, e la mamma le dice: «Vedi, Cecilia, quando morirai, il tuo corpo andrà sottoterra, ma se fai la brava, la tua anima, invece, salirà in cielo». Allora la bambina ha chiesto subito: «Ed io»? Istintivamente, non ammetteva che il suo io si riducesse all’ingranaggio di due pezzi alla morte separati.
Partiamo dunque dall’IO, e chiediamoci se abbiamo un’idea giusta del corpo e dell’anima. In poche parole: l’uomo non è il risultato della congiunzione di un corpo con un’anima: è tutto intero corpo e tutto intero anima. Mi spiego.
1) Il corpo umano non va ridotto alla materia, alla carne, che un giorno perirà. Sappiamo del resto dalla scienza che ogni individuo perde circa cinquecento milioni di cellule al giorno, che sono immediatamente sostituite da altre. Come osar pensare che il corpo si riduca a questo processo chimico in continuo cambiamento? No, si deve riconoscere che il corpo umano è ben altro; esso è ciò che mi permette di entrare in relazione con i miei simili.
Quando io vi parlo, utilizzo (senza pensarci) la materia delle mie corde vocali; sono loro che mi permettono di entrare in contatto con voi. Certo le parole non sempre hanno lo stesso significato per gli interlocutori, e il linguaggio che è il nostro mezzo per comunicare può essere anche causa di divisione.
Noi ci esprimiamo per mezzo del corpo, in particolare mediante dei gesti significativi. Senza corpo io non potrei esprimermi! Su questa terra il nostro io si esprime mediante la materia, ma un giorno, secondo la fede cristiana, potremo esprimerci diversamente, cioè mediante lo spirito. (Già oggi certe persone riescono a comunicare con altri mezzi che non la parola o i gesti). Inoltre il corpo dell’uomo è in relazione costitutiva con l’universo intero (influenza per esempio del clima sullo stato di salute), al punto che posso dire (senza esagerare) che il «mio corpo si estende fino alle stelle». Si può dunque dire a buon diritto che il corpo non è una parte di me stesso, ma è me stesso in quanto io mi esprimo.
2). E l’anima? Di solito si definisce l’anima come la «parte spirituale» dell’essere umano, dicendo che non è corporea. L’anima sarebbe qualcosa di etereo, di leggero, pronto a prendere il volo per tornare nell’azzurro, da cui viene e con cui ha affinità, mentre il corpo che è legato alla materia si corrompe nella fossa. Questo è il concetto che dettava la frase della mamma di Cecilia: «la tua anima, se fai la brava, andrà in cielo». Questo modo di concepire l’anima dipende dalla filosofia greca, è un sottoprodotto del platonismo. I Greci dicevano «sôma sèma», cioè corpo/carcere. Si doveva perciò fare il possibile per liberare l’anima da questa prigione.
Per i Greci, l’anima è un frammento di Dio; tende perciò con tutte le sue forze a ritornare nel mondo divino in cui esisteva da sempre, ma da cui è purtroppo precipitata per unirsi a un corpo. Da questa unione infelice occorrerebbe farla evadere. Questo modo di pensare ha dato luogo, in prosieguo di tempo cristiano, a delle concezioni erronee sulla mortificazione del corpo o sul distacco dal mondo che hanno provocato tristi conseguenze.
Per esempio, si diceva ai poveri di accettare la loro miseria e che sarebbero stati ricompensati in cielo; così la religione è stata detta «oppio del popolo». La concezione cristiana non può tollerare idee simili. Per noi cristiani, l’anima non è un frammento divino, ma una «crea tura» di Dio.
Come intendere allora il mistero della nostra «anima»? Per il pensiero biblico (cristiano semplicemente), ogni uomo è uomo a causa della sua relazione costitutiva con Dio; il suo essere dipende, in modo immediato, da Dio che lo tiene in vita, poiché (secondo la Bibbia) Dio solo è vita, è vivo nel senso forte della parola. Il libro della Genesi dice, simbolicamente, che Dio prese della polvere del suolo e soffiò su di lei un alito di vita, e allora l’uomo divenne un’«anima vivente». Secondo questo modo di vedere l’uomo è un essere sospeso a Dio per il fiato.
Non si deve dire che l’anima è immortale per natura, lo è solo per un dono di Dio, per il rapporto essenziale che l’uomo ha con Dio. Secondo la Bibbia, la nostra anima non è immortale di per sé, ma solo per grazia.
Avrete già capito che secondo 1’antropologia biblica, la morte non può essere detta semplicemente la separazione dell’anima dal corpo: quando un uomo muore, muore tutto intero perché è uno (tutto intero corpo e tutto intero anima). Attenzione, non ho detto che alla morte l’uomo è distrutto, ma solo che morire è cessare di vivere nel senso che l’uomo morto non può più esprimersi. Il mio Io continua ad esistere, dato che il Creatore mi ha suscitato nell’essere in dialogo e questo suo atto di amore per me è ormai irreversibile; ma non posso più comunicare con i miei simili non avendo più a mia disposizione il corpo che me lo permetteva. Ecco perché il Salmista diceva: «Nel sottoterra, chi può lodare Dio?»
Andiamo più a fondo, Per i cristiani, la risurrezione non consiste nel ricuperare la spoglia del corpo, il cadavere, ma nell’entrare in una vita piena e definitiva. Dire che l’uomo risorge, vuol dire che la sua capacità di esprimersi è ricreata. San Paolo parla allora di «corpo spirituale»: questo accostamento di termini non ha senso se si ritiene che «corpo» significhi soltanto materia. Alla risurrezione noi ci esprimeremo tramite lo Spirito Santo all’interno dell’unico corpo di Gesù Cristo.
3) Ho detto poco fa che, per un gran numero di Europei, la società è una specie di complemento dell’individuo: gli uomini vivono ciascuno di una sua vita personale, ma anche in società con altri. La società è allora qualche cosa che si aggiunge, un «in più» rispetto ai dati dell’antropologia. Invece, se si ascolta quello che dice la Bibbia, ci si accorge che l’uomo non è solo una «persona», ma esso è anche «società», o meglio è una persona appunto perché è un essere sociale. L’uomo è un essere paradossale, e il suo corpo stesso, che è strumento di comunicazione, manifesta che la dimensione sociale è costitutiva dell’uomo. Stando così le cose, «l’altro» non è semplicemente qualcuno messo accanto a me, ma è in un certo senso me stesso, fa parte di me dato che una relazione essenziale mi unisce a lui.
Molti falsi problemi sarebbero eliminati se si tenesse presente questo modo di pensare l’uomo.
Ad esempio, ancora a proposito dell’idea che ci facciamo del dopo-morte, è indispensabile situare la nostra esistenza futura non solo rispetto alla nostra sopravvivenza individuale e materiale (come quando ci si chiede: cosa succede del nostro corpo proprio?), ma anche rispetto ai nostri fratelli con cui vogliamo restare in relazione. (Mi manca il tempo di approfondire questo punto).
Riassumiamo: l’uomo è tutto intero corpo e tutto intero anima. Per mezzo del corpo sono in relazione con l’universo e con gli altri uomini; l’anima è il mezzo per cui sono in relazione con il Dio vivente. Queste due relazioni sono costitutive di me.
Potrei quindi definire l’uomo come un «essere dialogale»: in dialogo con Dio, in dialogo con gli uomini.
Vediamo allora quali siano le condizioni di un dialogo vero.

II. CONDIZIONI DEL DIALOGO
Se io sono costituzionalmente in relazione con l’altro, devo scoprire e precisare le condizioni necessarie perché ci sia dialogo. Qui l’esperienza che tutti abbiamo della sessualità ci aiuta. Il tema della sessualità era considerato tabù, ma è fondamentale per comprendere il nostro essere in quanto sociale. Adopererò una formula un po’ paradossale: la sessualità è la vita sociale in miniatura (in condensato).
1. L’amore e la sessualità
Nel Vecchio Testamento, la differenza sessuale è inizialmente connessa con l’idea che l’uomo è stato creato «a immagine di Dio». I redattori di questo testo (che ricorre due volte nella Bibbia) assumono due punti di vista. Il redattore sacerdotale (P) si limita a collegare la differenza sessuale tra l’uomo e la donna con la fecondità di Dio che trasmette la vita e domina l’universo (Gn 1,28). Il punto di vista dello Jahvista (J) è più completo. A suo parere, quel che sta alla base della differenza sessuale, è la necessità per l’uomo di vivere in società: «Non è bene che l’uomo sia solo. Bisogna che gli dia un aiuto simile a lui» (Gn 2,18). Alla fecondità che non è trascurata da questo autore, si associa qui il rapporto di altero dei sessi. Entrambe queste motivazioni inseriscono l’individuo in un contesto sociale.
Idealmente nel clima paradisiaco l’incontro dei sessi ha luogo nella semplicità: «Benché. fossero nudi Adamo ed Eva non avevano vergogna l’uno dell’altro» (Gn 2,15). Ma Il peccato, separazione da Dio, introduce distanze e paura. Ormai la relazione sessuale è diventata ambigua. Non cessa di essere fondamentalmente buona, però è caduta sotto l’influsso della forza di divisione rappresentata dal peccato.
Al posto della gioia di fronte alla irriducibile differenza dell’altro, subentra nei partner il desiderio egoistico del possesso (Gn 3,16). L’impulso sessuale, che porta di per sé all’estroversione, è perturbato da un movimento di introversione: anziché volgere verso l’altro, ripiega su di sé.
Con l’istinto sessuale, che orienta un sesso verso l’altro, si può dire che Dio ha inserito nel cuore dell’uomo una semente di fuoco che lo spinge all’amore verso l’altro. È così che un giovane trova il coraggio e la forza di uscire dalla propria solitudine e dal suo comodo egoismo, e si prende il rischio di fondare una famiglia. So bene che il matrimonio è un’impresa ben difficile e che spesso fallisce, basta vedere i divorzi che si moltiplicano attualmente per rendersi conto del carattere azzardato dell’impresa! Ma è un fatto che i due sessi continuano a dipendere l’uno dall’altro e l’amore umano mostra, come in un’esperienza di laboratorio, che l’uomo è per natura un essere sociale. Vediamo dunque quali siano le condizioni di un dialogo autentico tra gli uomini.
2. Non essere pieno di sé
1. La prima condizione, elementare, dipende dalla tendenza spontanea, che è la nostra, di rinchiuderci nella nostra solitudine; ora, questa tendenza contraddice il progetto del Creatore: «Non è bene che l’uomo sia solo». Se è vero che la sessualità fa fare i primi passi di vera apertura verso l’altro, è chiaro che siamo tutti inclini a rinchiuderci sulla nostra propria felicità, sui nostri interessi, senza renderci conto che la nostra gioia richiede sempre l’apertura verso l’altro. Le nostre opinioni le abbiamo acquisite a poco a poco, abbiamo accumulato dei beni che sono diventati la nostra proprietà e siamo pronti a difenderli a ogni costo come un diritto.
In queste condizioni, il rapporto con l’altro è quello di due individualità che difendono ciascuna gelosamente il proprio avere. In tal caso, si può dire che la coesistenza tra uomini è soltanto cessazione di conflitto; del resto i greci definivano la pace: «cessazione della guerra». Per un cristiano, la pace invece è la pienezza dei beni, è la salute totale, il che presuppone che si è passati dall’«avere» all’«essere». Purtroppo la maggioranza degli uomini si barrica nel possesso dei propri averi, o del proprio sapere.
Ma l’altro come può entrare in contatto con uno che si difende, barricandosi nella fortezza delle sue convinzioni e dei suoi interessi? Il contrassegno di questo tipo di condotta è la mancanza della capacità di ascolto. Si è talmente presi dai propri desideri, dai propri problemi, dai propri diritti che l’altro, che viene verso di me, urta immediatamente contro il muro del mio «io» ben difeso, contro la fortezza che ho costruito per proteggermi dalle aggressioni della società. Certo, queste aggressioni esistono, ma non è così che si potrà stabilire un clima di amore e di dialogo. Come fare per dimenticare sé stessi al punto da poter fare «esistere» l’altro? Un racconto mi pare venire a proposito per quello che voglio dire. È una storia molto edificante, ma anche pericolosa per l’esistenza della società.
Un certo Giovanni da Kenty, un canonico polacco che viveva nel 1400, era professore di teologia a Cracovia. Un giorno, essendo stanco di insegnare, si decise di andare a Roma in pellegrinaggio. La sua perpetua lo avverti che gli aveva cucito nella fodera del suo abito talare un borsellino di riserva. Gli disse: «Lei rischia di incontrare per strada dei banditi che la possono svaligiare e lasciarla senza un soldo per continuare il viaggio». Per farla breve, il pellegrino si mette in cammino per Roma. Naturalmente incontra dei banditi, che gli dicono:«o la borsa o la vita». Allora egli consegna il portafoglio e continua tranquillo la sua strada, cantando salmi. Ma tutto a un tratto si ricorda di avere un secondo borsellino a11’interno del vestito. Allora torna indietro di corsa, ritrova i banditi, si mette in ginocchio davanti a loro e li prega di scusarlo di non a ver consegnato tutto subito: essi avevano certamente bisogno di denaro e lui ne aveva! Ora, ascoltate che cosa è successo: non solo i ladri non accettarono la seconda borsa, ma restituirono al pellegrino la prima…
Che cosa era avvenuto nella mente dell’uno e degli altri? Giovanni da Kenty era entrato così profondamente nel pensiero e nel desiderio dei banditi, suoi interlocutori, che questi si sono trovati in uno stato di comunione con lui e allora, a loro volta, hanno preso a cuore quello di cui lui aveva bisogno, perciò gli hanno reso tutto perché potesse vivere anche lui. Naturalmente questa storia non può servire da modello al Codice penale, è evidente, poiché, se tutti facessero come Giovanni da Kenty, non ci sarebbe più giustizia, Ma è bene esistano uomini di questa tempra, cioè talmente aperti al pensiero altrui che gli altri entrano in comunione di pensiero.
Tiriamo un insegnamento generale da questo episodio. Ogni incontro con l’altro presuppone l’apertura di quel muro che edifichiamo spontaneamente contro le intemperie della vita in società. Questo blocco che si trova in tutti si fa notare più o meno fortemente. Sentiamo subito che una determinata persona è talmente preoccupata dai propri affari che non è possibile entrare in un vero dialogo con lei.
Avete sicuramente fatto, anche voi, una esperienza comune: siete in un momento difficile, volete parlarne con una persona che sembra interessarsi a voi, ma, non appena vi mettete a parlare del vostro problema, ecco che l’altro dice subito: «E io allora! anche per me è così, mi è successo questo e quest’altro» e vi inonda dei fastidi che ha lui. Forse lo fa con buona intenzione, per darvi l’impressione che vi può capire, avendo avuto un’esperienza analoga.
Ma a voi la sua esperienza non interessa affatto in quel momento, non è questo che cercate, ma un orecchio che vi ascolti con attenzione, nient’altro.
Ma l’orecchio del vostro interlocutore è ingombro dal fatto che lui è presente solo a sé stesso.
Il blocco di cui parlavo si riduce talvolta a essere solo una piccola cisti una palla senza niente dentro che si è formata in noi a poco a poco per preservare una parte di noi stessi, in cui nessuno possa entrare. Certo, è importante avere un’esistenza personale, e in certo senso autonoma, ma bisogna sapere che non incontreremo mai veramente l’altro, se non il giorno in cui questa cisti sarà scoppiata o il giorno in cui, come Giovanni da Kenty, saremo disposti a percepire ciò di cui l’altro ha bisogno, senza cercare quello che interessa noi. Per incontrare l’altro è necessario essere liberi da noi stessi, direi vuoti dalla fissazione su noi stessi.
3. Conoscere, stimare, amare l’altro
Non basta essere aperti, accoglienti, occorre anche scoprire a poco a poco chi è l’altro, arrivare a conoscerlo nel senso biblico del termine, cioè un po’ come Dio ci conosce e ci fa esistere.
Mi ricordo come fosse ieri di una conferenza che ho fatto a Mulhouse vent’anni fa alla sede delle Amicizie giudeo~cristiane davanti a un pubblico di ebrei e di cristiani. Non ricordo di che argomento ho parlato, ma so che ci fu una serata di incontro e di scambi, durante la quale gli ebrei hanno rimproverato sia a me che ai cristiani in genere di avere un atteggiamento di superiorità verso di loro: noi crediamo di possedere la verità e perciò pensiamo spontaneamente che gli ebrei siano in una condizione inferiore in quanto non riconoscono la divinità di Gesù e allora noi desideriamo che si «convertano» e nell’attesa facciamo loro il favore di una certa compassione.
Questo atteggiamento urta terribilmente gli ebrei, e con ragione. Ma l’incontro tra cristiani ed ebrei è arduo. Tentiamo di mostrarne le tappe.
Il primo passo da fare è quello di far conoscenza. Devo cioè cercare di conoscere il mio fratello ebreo: lo considero o no una persona importante per me? Che cosa so di lui? Oppure sono indifferente a conoscere intimamente colui che resta sempre il depositario naturale della Promessa di Dio? Lo considero solo come un convertito potenziale? Mi interesso al suo modo di pregare Dio? Mi do’ cura di partecipare alle celebrazioni della sua liturgIa, al suo modo di celebrare e di intendere la Pasqua, per esempio? Quante domande ci potremmo fare in questo campo, ma preferisco qui approfondire il mistero dell’incontro con l’ebreo.
Il secondo passo da fare è ancora più difficile: non c’è vera conoscenza, completa, senza un «riconoscere». Per riconoscere, intendo sia l’atto con cui si conosce una seconda volta (come si dice riconoscere un debito) sia nel senso di riconoscenza cioè di gratitudine verso qualcuno. Conoscere senza riconoscere significa in realtà non conoscere affatto, poiché non si arriva a una comunione profonda.
Posso conoscere veramente l’altro solo se mi sento dipendente da lui, pienamente dipendente.
Dipendere da lui? Com’è possibile questo? Credo che non solo sia possibile, ma necessario se si vuole arrivare a un incontro vero. Questo vale anzitutto al livello delle persone che si considerano di uguale livello (inutile insistere), ma ciò vale anche quando a buon diruto si può ritenere che l’altro sia «inferiore» a noi in qualche modo. È impossibile fare autenticamente l’elemosina se non ci si rende conto che in realtà siamo noi che riceviamo di più: che cos’è dare dei soldi o un oggetto, che cos’è questo «avere» in confronto con la persona che ci sta davanti?
Statemi bene a sentire: dare a qualcuno, è in primo luogo ricevere tutto da luI, Allora sì, ci può essere una vera «comunione» tra il donatore e il ricevente, perché si passa dall’avere all’essere.
Più in profondità, la questione si pone tra persone che non condividono la stessa fede. Quando incontro un ebreo, non devo abdicare le mie convinzioni di fede e supporre per esempio che Gesù non era il Messia o che non è risorto. No! Non devo rinunciare alla mia persuasione di essere nel vero.
Ma, d’altra parte, non devo partire dal principio che lui deve «convertirsi» dall’errore alla verità. Fare così, sarebbe esistere ciascuno per conto proprio, senz’altra speranza che per entrare veramente in contatto e per vivere una comunione reciproca sia necessario che l’uno ceda all’altro, cioè che uno dei due rinunci alla propria fede (conversione), dunque a quello che per lui è la verità, o che l’uno faccia all’altro l’elemosina della verità propria.
Questo problema sembra complicato e grave, ma le cose andrebbero meglio se si potesse mostrare che tutti, attraverso delle formulazioni diverse del nostro pensiero, siamo alla ricerca della Verità con la V maiuscola, della Verità personificata, e che certe formulazioni sono adatte per cogliere il mistero (per poco che sia), mentre altre non lo sono. Il fatto è che il mistero rimane intero al di là delle nostre formulazioni diverse. Non dovrei, per amore, rinunciare a questa o quella formula per cercare di capire il modo di esprimersi dell’altro? Allora potrei tendere con lui, in sua compagnia, verso il mistero che anch’io vorrei approfondire e a cui credo. Senza questa rinuncia alle formule non ci può essere un’intesa valida nella ricerca comune della verità, i due esseri restano paralleli, non entrano in comunione reciproca.
Devo dunque riconoscere che il mio fratello ebreo può tendere in modo autentico verso il mistero di Dio e produrre per questa sua via dei risultati che possono anche essere migliori dei miei; allora mi trovo a dipendere da colui che, oggettivamente, al livello della formulazione teologica, è ancora a una tappa anteriore alla mia Potrei sviluppare questa proposta parlandovi del senso della «giustizia» o del «perdono delle offese» o in genere di certi valori presenti nella Bibbia e di cui gli Ebrei sono penetrati congenitalmente fin dalla nascita e che, invece, per noi sono oscurati a causa del nostro passato pagano, sia greco o altro.
4. Amare fino a rischiare la propria vita
Nella parabola del Buon Pastore secondo Giovanni, Gesù descrive il Buon Pastore e il Mercenario. Quest’ultimo vive nel regime dell’«avere» e del «denaro», non si preoccupa in realtà del le pecore che non sono sue e, se viene il lupo, abbandona le pecore; lo stesso se viene un ladro o un nemico. Invece il Buon Pastore, che considera le pecore come sue proprie, non esita a rischiare la sua Vita per salvarle dal lupo. La differenza dal mercenario è che il Buon Pastore vive nel regime dell’«essere». Tra lui e le pecore c’è una conoscenza reciproca segreta; il testo dice che il Pastore le chiama ciascuna per nome, col nome a lei proprio.
Ma perché mette a rischio la propria vita? Il segreto di questo comportamento sta nella relazione che Gesù ha con Dio suo Padre: se mette a rischio la propria vita è perché sa che Dio gliela ha data e gliela garantisce: se va fino in fondo alla missione ricevuta, anche se deve dare la propria vita per le pecore, Dio gliela ridarà pienamente. Nessuno può strappare le pecore dalla mano del Padre e il Pastore sa che l’amo re è più forte della morte. Così il Pastore vive nel registro dell’«essere», cioè in quello dell’amore, e sa che Dio è lì, e che l’Amore avrà l’ultima parola.

Conclusione
Per concludere, vorrei ricordarvi il dialogo per eccellenza che il Cristo risorto ha avuto coi suoi discepoli: parlo di quello che noi designiamo col termine «apparizioni» del Risorto. I racconti di apparizione presentano uno schema a tre dimensioni:
- Gesù ha l’iniziativa della sua venuta (infatti il suo apparire è improvviso e imprevisto…);
- dicendo «Sono proprio io!» Gesù fa comprendere ai discepoli che c’è identità tra Colui che si presenta così improvvisamente a loro e Colui che avevano conosciuto in passato, e ottiene cosi il riconoscimento da parte loro della sua identità;
- infine Gesù dà una missione ai discepoli. Questa triplice dimensione caratterizza ogni incontro profondo tra noi e gli altri. Prendiamo per esempio il caso di due persone che vogliono sposarsi.Uno di loro ha avuto la prima iniziativa, ma poi bisogna che tutte e due imparino a conoscersi a fondo; parlando tra loro di sé e del loro passato rispettivo; infine c’è un progetto per il futuro, quello di costruire una coppia, di fondare una famiglia.
Ogni incontro presuppone un itinerario: passare dal «vedere» (il volto qualcuno, la sua bellezza, il tipo che è) all’ascolto (la concezione della sua vita, gli episodi della storia di ciascuno…), infine passare a un «creare» insieme (dei figli, un’opera d’arte o altro). Incontrare l’altro è un’avventura, certo, piena di rischi, ma che è sempre feconda.
Essa suppone un adattamento continuo al temperamento e alla situazione dell’altro.
Nessun tag per questo post.