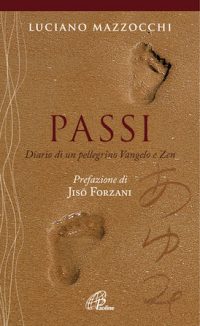«In quel tempo: vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.»
* Beati nel futuro del presente
I riverberi che il Vangelo delle otto beatitudini suscita in ognuno sono oltre il calcolo umano, sia nella profondità, sia nella varietà. È opportuno astenersi dal frapporre commenti di sorta tra le parole sante di Gesù che annuncia le otto beatitudini e l’orecchio del cuore dell’uomo che le ascolta. Nel Vangelo secondo Matteo le otto beatitudini costituiscono l’esordio del discorso della montagna che inaugura la predicazione universale del Vangelo. Soffermiamoci solamente ad assaporare alcuni profondi significati del comportamento di Gesù prima di aprire la sua bocca e proclamare le otto beatitudini. Nessuno va accanto ai petali dei fiori con la pretesa di abbellirli, ma semplicemente zappa il terreno circostante e lo innaffia: anche noi zappiamo un po’ il terreno della nostra disponibilità ad ascoltare.
«Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli». La beatitudine annunciata dal Vangelo non scende magicamente dal cielo, ma sale dalla terra. E questa salita inizia dall’osservazione attenta della folla così com’è, sotto il peso di tante contraddizioni. Nel corrispettivo brano delle beatitudini riportato in Luca (Lc 6,17-23), Gesù è descritto non nell’atto di salire la montagna, ma di scendere verso la valle dove è radunata una grande folla venuta da tutte le parti: malati, soggiogati da forze del male ecc. E tutti cercavano di toccarlo. Alle due descrizioni apparentemente opposte sottostà un unico significato: il Vangelo delle beatitudini è stimolato in Gesù dal rapporto coinvolgente che egli viveva con la realtà cruda della gente. Gesù scende dov’è la folla, secondo Luca; Gesù guida la folla sul monte, secondo Matteo. il cuore che discende verso valle è il cuore che attira in alto: è l’unico cuore della misericordia.
La beatitudine proclamata da Gesù spazia sotto il vasto cielo che avvolge l’alta montagna e si posa su tutta la valle della realtà, così come si posa la luce del sole. Senza il presente della realtà così com’è, senza la carenza delle cose che rende i poveri veramente poveri, senza i contrasti che rendono i miti veramente miti, senza la sofferenza che rende i sofferenti veramente sofferenti, senza le ingiustizie che rendono i giusti veramente affamati e assetati di giustizia, il Vangelo delle beatitudini non ha senso.
«Salì sul monte». Indica che le beatitudini scattano quando l’uomo che osserva la realtà si mette in cammino e suda per salire verso l’alto, portando dentro di sé la realtà, portandola in alto con sé. Fuori da tale tensione la povertà rimane soltanto penuria, la sofferenza soltanto dolore, l’ingiustizia soltanto sconfitta, la guerra soltanto violenza.
«E messosi a sedere». La realtà cruda dell’uomo, semplicemente osservata e semplicemente trascinata verso l’alto dallo sforzo dell’uomo forte, rimane ancora fuori dalla beatitudine. Può assurgere a eroismo, ma non è beata. Come un campo dissodato, arato, concimato con molta cura e sudore; bisogna che il lavoro dell’uomo lasci posto alla pioggia del cielo, affinché il campo di frumento scoppi di vitalità. L’uomo religioso deve sedere su un sasso o sull’erba della montagna che ha scalato, portando dentro di sé il destino del mondo intero. Sedere e basta: con calma, lasciando riposare e il corpo e la mente. Nello Zen questo atteggiamento fondamentale è coltivato della pratica dello zazen: silenzio del corpo za e dello spirito Zen. Sedersi significa mettersi in profonda comunicazione con la fonte della realtà, senza frapporre pregiudizi o programmi di sorta. Proprio la realtà nella cui storia pullulano le contraddizioni della folla a valle e le idealità che spingono a salire la montagna. Sedere finché questi due opposti comunichino dentro di sé e si manifestino come uno: la sofferenza e la gioia, la negatività e la positività, il peccato e la grazia.
Mettersi a sedere è il passaggio più carente nella nostra Chiesa, sempre tentata a vedere la folla, salire sul monte e subito mettersi a parlare, senza prima aver taciuto ed essere visitata nel silenzio dall’uno che evangelizza gli opposti. Sediamo davanti al Signore, fino al punto che l’atteggiamento del Signore diventi il nostro. Così diventiamo Chiesa che siede nobile davanti al mondo proclamando gli uomini otto volte beati.
p.Luciano

* Né cuore né Budda
Se dovessimo indicare con una parola sola l’atmosfera, il carattere, la forma dello Zen (consci di non dire che una punta di iceberg, quale che fosse la nostra scelta) non sbaglieremmo troppo, credo, se scegliessimo la parola montagna. Più ancora che il monte in se stesso, il termine montagna (nelle sue varie pronunce in giapponese yama, san, zan, sen) è usato per dire tante altre cose che sono elementi fondamentali dello Zen. Montagna è il panorama, lo sfondo, montagna è il monastero (e porta della montagna è il cancello d’ingresso), montagna è il cuscino su cui sedere in zazen. Salire al monte e scendere dal monte sono le espressioni per dire entrare in monastero e uscirne. Al nome di ogni maestro che ha vissuto la via in modo esemplare è aggiunto spesso il nome di una montagna. Montagna è, infine, ogni individuo, inteso come l’insieme di tutto ciò che lo compone e lo rende unico: proprio come una montagna non è che l’insieme di infiniti elementi, particelle infinitesime adunate a formare un gigante. Ecco, quest’ultima montagna riassume ed esprime tutte le altre: l’inamovibile solidità, il solitario svettare, fatto di infiniti elementi di microscopica piccolezza, perennemente cangianti, la forza che li tiene insieme e quella che li muove, che operano nello stesso fenomeno. Una montagna che non è come sembra, che non sembra come è: che non è montagna come noi la pensiamo. È la montagna della nostra vita, di ogni vita.
Su questa montagna sale Gesù, si mette a sedere, apre la bocca per parlare: con queste parole è descritto anche l’inizio di molti dei sermoni di Budda. Da questa montagna parla della beatitudine. Non è la beatitudine come noi la pensiamo: anzi sono detti beati molti che noi chiameremmo infelici: i poveri, gli afflitti, i perseguitati. Sono detti beati ora nella condizione di povertà, di afflizione, di infelicità in cui si trovano (ci troviamo) proprio adesso: la beatitudine non si riferisce al premio futuro, ma a quell’insieme di sofferenza, memoria, speranza che dà forma alla realtà presente. È la beatitudine della nostra vita, di ogni vita.
Saliamo sulla montagna che siamo, mettiamoci a sedere, ascoltiamo la beatitudine che siamo. Per ascoltare, però, dobbiamo smettere i nostri criteri: dobbiamo comprendere che quella montagna è una non montagna e quella beatitudine una non beatitudine. Su quello stesso monte un antico maestro diceva «Né Cuore né Budda». Cuore e Budda sono ciò che di più sacro ha un buddista: negando in questo modo, non si annulla niente, ma si sfugge alla tentazione di manipolare. Ascoltiamo, sul monte, la voce vivente che dice né Cristo né Regno.
Jiso

* Dalla fuggevole felicità all’eterna beatitudine
La felicità è uno stato d’animo momentaneo, legato a circostanze esterne particolarmente piacevoli: il superamento di un esame, un incontro con la persona che si ama, la realizzazione di un progetto, l’acquisto di un bene che si desiderava da lungo tempo… Ma la felicità forse più intensa consiste nell’attesa che ci separa dalla realizzazione dì quel sogno che da tempo custodivamo nel cuore. In molte delle poesie del Leopardi viene colto con grande sensibilità questo aspetto della felicità come attesa di qualcosa di bello e di piacevole che sta per avverarsi.
In ogni caso comunque la felicità è destinata a poco a poco a diminuire di intensità fino a spegnersi: il fatto piacevole che ci è accaduto e che ci aveva riempito il cuore di gioia perde col tempo la sua nitidezza e ci coinvolge emotivamente sempre meno; analogamente la realizzazione del sogno che custodivamo nel cuore segna inesorabilmente la fine della gioiosa attesa.
La beatitudine invece è una condizione stabile e duratura: è completezza. Essa sgorga quando, accettando la propria imperfezione e il proprio limite, cessa la tensione diretta all’esterno allo scopo dì colmare quelle mancanze che sembrano essere gli ostacoli che ci impediscono di essere felici.
La povertà, ad esempio, diventa beatitudine, se è accettata e non si cerca affannosamente di vincerla attraverso la ricchezza: beati i pover i ci ricorda Gesù. Queste sue parole sono da intendersi come una severa e definitiva condanna per chi possiede dei beni? In realtà questo ammonimento di Gesù deve calarsi nel nostro cuore e nella nostra vita trasformandola: è cioè l’indicazione di un cammino che dobbiamo seguire.
Che cos’è la povertà? Taluni si sentono poveri perché non hanno i mezzi per comperarsi abiti firmati o per concedersi viaggi e vacanze; ci sono genitori che si sentono poveri perché, pur avendo il necessario per vivere dignitosamente, non possono permettersi di far frequentare ai figli le scuole superiori. Ci sono poveri che non hanno di che sfamarsi.
La beatitudine della povertà è uno stimolo per noi a scoprire ciò che è autentico ed essenziale e inizia dal non ritenere inadeguato il nostro tenore di vita e dal modificare la nostra scala di valori avendo l’avvertenza di mettere ai primi posti ciò che è veramente importante. Ma cambiare la propria scala di valori significa cambiare profondamente se stessi. In realtà infatti muta in modo radicale il nostro rapporto con le cose: non le percepivamo più come un fine, ossia come ciò da cui dipende la nostra felicità, la nostra realizzazione, ma come un semplice mezzo e il loro venir meno, a seguito di circostanze impreviste, non provocherà in noi uno stato di angoscia e di smarrimento.
Se questo processo di crescita si è attivato quali sono i segni che lo rendono manifesto? Si diventerà capaci di opporsi alle martellanti lusinghe della pubblicità e ai modelli di vita artefatti che questa e i mass media propongono. Si diventerà naturalmente capaci di essere generosi, si sperimenterà non la felicità fuggevole del possedere, ma l’eterna beatitudine del dare.
Annamaria Tallarico
Nessun tag per questo post.