Vangelo e Zen, 31 marzo 2017
Molti amici mi hanno condiviso le loro impressioni sul film SILENCE, tratto dal romanzo Chinmoku (Il silenzio) di Endō Shūsaku, regia di Martin Scorsese. Ne elenco alcune: stupore, perplessità, bellezza, miseria, contraddizioni, mestizia, natura, violenza, fede, storia umana e tanto altro. Qualcuno ha tratto beneficio anche dai cenni storici della mia precedente lettera. Giorgio, un carissimo amico, aggiunse una sua richiesta: “Perché non ci descrivi la tua impressione come missionario?”. Eccomi, quindi, a dire qualcosa, che – mi auguro – sia utile anche a chi non ha visto il film. Il film è solo un’occasione qualificata per meditare sulla vita.
Dalla sollecitazione di Giorgio sono passate due settimane e nel frattempo SILENCE, silenziosamente, ha sempre intrattenuto la mia mente, suscitando ricordi e stimolando visioni. Mi sono chiesto quale sia la parola ricorrente nel film che può raccogliere in un pensiero di fondo le varie impressioni che ne ho riportato. Alla fine la parola che mi è rimasta è questa: PALUDE. E’ la parola con la quale l’inquisitore Inoue e Ferreira, il missionario che aveva abiurato, cercarono di convincere il missionario Rodrigues ad abiurare la fede cristiana. Palude è una immagine che ricorre ripetutamente negli scritti di Endō Shūsaku. Il Giappone è una palude e le piante ivi trapiantate da fuori, sulle prime esplodono in foglie rigogliose per l’abbondanza di umore, ma poi lo stesso umore inesorabilmente le fa seccare e marcire.
Palude non fu soltanto il Giappone dello shōgun per i missionari venuti dall’occidente. Palude non è un fenomeno circoscritto a una particolare epoca storica o area culturale. Palude è la qualità originaria della nostra esistenza. Siamo palude e nella palude lo sbaglio più grave è corazzarsi, appesantirsi.
Il film Silence per due ore e quaranta minuti trattiene lo spettatore nella sensazione della palude. Lo spettatore si sente con i piedi nel fango. E’ la palude dei poveri contadini e pescatori cristiani di Nagasaki, ma è pure la palude dell’arroganza politica dello shōgun e della sicurezza teologica dei missionari. Alla fine del film, dopo proclami di potere e ragionamenti teologici, che cosa rimane? Rimane la scena di una vedova non cristiana, che avvolge in un foglio di carta di riso un piccolo oggetto e lo pone sul petto della salma del marito. Il marito era Rodrigues, il missionario portoghese che aveva abiurato. L’oggetto era la piccola croce che il Jisama, l’anziano che guidava la comunità dei cristiani nascosti, aveva costruito con le sue mani. Questa piccola croce, dopo il martirio del Jisama sulla croce eretta sugli scogli del mare, era stata affidata al missionario Rodrigues, il quale la tenne sul suo ventre, nascosta sotto gli abiti, anche mentre compiva l’atto di abiura calpestando l’immagine di Gesù e di Maria. Mentre calpestava, custodiva. Le fiamme appiccicate alla bara bruciarono tutto.
La palude è questa natura umana, debole e forte assieme, per cui l’uomo avanza verso la verità solo traballando, e ricerca la purezza solo infangandosi. I poveri pescatori e contadini di Nagasaki avevano sentito vero nella loro vita il Vangelo di Gesù che annuncia che il peccatore che vive nella palude della sua umanità convertendosi giorno dopo giorno, porta nell’universo una gioia più grande di chi, per non peccare, vive senza toccare terra. In quel Vagelo si erano sentiti accolti e confortati. Sgorga da questa fede la mitezza dei volti del Jisama, di Mōkichi, della giovane coppia e degli altri cristiani nascosti. Nella palude della situazione hanno saputo morire con la mitezza umana sul volto. Il capolavoro nel capolavoro: l’inno cantato con voce limpida, calda, sommessa, da parte di Mōkichi sulla croce aggredita dalle furiose ondate del mare, mentre l’inquisitore osservava impavido e gli altri cristiani pregavano in silenzio. Anche il corpo dei tre martirizzati dalle onde saranno bruciati e le ceneri disperse nell’oceano. Il Jisama e Mōkichi avevano calpestato le sacre immagini di Gesù e Maria, assaporando fino in fondo la palude della costrizione storica e del limite della loro umanità. Ma, con i piedi nella palude si rialzarono. Meglio, non erano mai caduti. Avevano saputo vivere rimanendo nella loro umanità, con la sapienza che nel pericolo sa fuggire da una città all’altra e con il vigore di chi sa morire nel momento in cui si deve morire. Senza alcuna arroganza sulla propria esistenzialità, senza avvilirla nel fatalismo rassegnato, né corazzarla in presunte sicurezze. Né la presunta sicurezza politica dello shōgun, né quella teologica dei missionari. Ma solo umanità debole – forte, forte – debole, umanità reale.
Il film Silence mi ha suscitato nel cuore l’affetto religioso verso la palude della mia esistenza e della storia umana intera. Il Jisama e Mōkichi sulla croce in balia dei marosi dell’oceano morirono con la mitezza e la soavità sul volto. Soavità che non era sui volti né delle guardie dello shōgun, né dei missionari venuti dall’occidente, saturi di teologia. L’idea di Dio rende arrogante l’uomo che la pensa con la mente arrogante.
Anche nel catechismo tradizionale, Dio, prima di essere tre persone distinte, è uno come natura divina. La natura che precede ogni vantata singolarità che separa e contrappone, tale natura che non è né io, né tu, né lei o lui, questa natura è mite e soffice. E’ la palude dell’esitenza, divina, umana, cosmica.
Amo i sacramenti dove, nell’acqua, nell’olio, nel pane, nel vino, nel calore delle mani che un vescovo anziano posa sul capo di un giovane candidato al sacerdozio, nel calore che si irrora nell’unione del corpo femminile e di quello maschile che nudi si abbracciano, nello sguardo perplesso di un penitente che si incontra con quello benevolo del sacerdote che gli dà il perdono: amo questa palude dell’esistenza dove la vita si rigenera e dove la vita va a confluire. Amo il nascere, amo il morire. Sorrido su questo mai potermi proiettare oltre l’ombra della mia paludosa esistenzialità. Amo non poter mai dire che ho visto Dio. Se lo vedessi, mi sarebbe fuori. Ogni fede indotta da fuori ciò che l’uomo realmente è, questa marcisce nella palude di ciò che l’uomo realmente è. E’ marcita la presunta centralità cronologica e geografica dell’uomo nell’universo. Oggi quello che ci rimane è che l’umanità costituisce un lembo infinitesimale di quanto esiste. Le miriadi di stelle ci ignorano.
Amo questa infinitesimalità. Amo la via missionaria, lungo la quale il sovrappiù del mio bagaglio di fede e di conoscenza, va seccando e marcendo. Amo riconoscere, alla fine, che nessuna prova da fuori mi convince a credere. Sarebbe solo commercio di prodotti importati. Così mi ritrovo a credere senza uscire dalla palude di ciò che sono. Credo, senza sostegno indotto; credo senza demandare altrove. Credo senza posarmi su nulla oltre ciò che sono. Sperimento Dio. Quando ogni io indotto scompare, l’io che rimane non è di alcun mio io individuale. E’ il mio io di Dio. Credere Dio è credere il paradiso. Così credevano i cristiani perseguitati, mentre erano nella palude della persecuzione. La prova del paradiso era il paradiso che era dentro di loro. Ma non era un paradiso trionfante come dicono certi inni. Era il paradiso umile di chi crede abitando la palude del tempo. In un certo senso, nella palude del tempo anche dopo morte, perché anche dopo morte più che la propria beatitudine sta a cuore attendere tutti, insieme con Gesù che berrà il frutto della vite soltanto quando il passaggio sarà completo.
Non ho alcuna prova di Dio indotta da fuori. Credo Dio: quando tutto cade, ciò che non cade è Dio. Nella palude che tutto fa marcire, quel che invece risorge è divino. Su una croce aggredita dalle onde del mare, un uomo dal volto mite, moriva cantando un inno. Mōkichi.
Oggi con Isacco andrò ancora al cinema, a vedere YOUR NAME di Makoto Shinkai. La locazione di questo anime è la stessa montagna dove sorge l’eremo Sōan Takamori di padre Oshida e di suor Kawasumi (villaggio SUWA, provincia di NAGANO). p. Luciano

la tomba di p. Oshida all’eremo Takamori: un tumulo di terra e alcuni fiori (nostra foto)
Nessun tag per questo post.



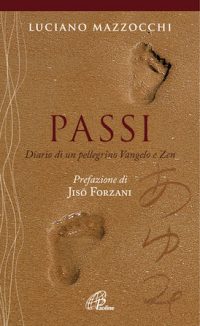


Il pezzo è scritto bene, tra il poetico e l’ispirato. Però “Quando ogni io indotto scompare, l’io che rimane non è di alcun mio io individuale. E’ il mio io di Dio” mi sembra un filino azzardato. Pericoloso, se si considera che il passo successivo è: io è Dio.
Comunque la parte più interessante è la data… :-D